La scienza dietro il desiderio
Chicago, primi anni del Novecento. Una stanza in penombra, scaffali pieni di scatole, appunti sparsi. Sul tavolo, un uomo sta aprendo decine di lettere. Le legge una per una, annota, confronta, divide in pile. Non è un impiegato postale, né un contabile. È Claude C. Hopkins. E quelle lettere non sono semplici messaggi: sono risposte a un annuncio pubblicitario. Ogni busta è un dato. Ogni dato, una traccia del comportamento umano. E Hopkins lo sa: se riesce a capire cosa ha convinto qualcuno a scrivere, potrà ripetere quel successo, sistematizzarlo, renderlo replicabile. È l’inizio di qualcosa di nuovo. La pubblicità non sarà più solo un’arte. Diventerà anche una scienza.
Chi era Claude Hopkins?
Non è facile collocare Hopkins in una sola definizione. Fu copywriter, consulente, teorico, ma soprattutto fu un artigiano dell’attenzione.
Nato nel 1866, lavorò per alcune delle più grandi agenzie pubblicitarie americane, ma il suo nome iniziò davvero a circolare con la pubblicazione, nel 1923, di un libro che sarebbe diventato un punto di riferimento per generazioni di marketer: Scientific Advertising.
In quel testo, Hopkins rompeva con la tradizione romantica e istintiva della pubblicità. Per lui, ogni annuncio era un esperimento. Ogni parola, una variabile da testare. Ogni risposta del pubblico, un risultato da analizzare.
Non si trattava più solo di essere creativi. Si trattava di essere efficaci.
Il sapone, il dentifricio, il gusto del risultato
Una delle campagne più celebri che lo rese famoso fu quella per il dentifricio Pepsodent.
Prima di Hopkins, nessuno considerava la pulizia dei denti una priorità. Non esisteva una vera abitudine collettiva legata al lavarsi i denti ogni giorno.
Ma Hopkins ebbe un’intuizione: trovò un piccolo elemento comune — quella pellicola che si sente sulla superficie dei denti — e la trasformò in un nemico. Iniziò a scrivere slogan che parlavano di quel rivestimento che opacizza il tuo sorriso.
Non parlava di salute. Parlava di bellezza. Di fascino personale. Di auto-percezione.
E poi offriva una soluzione chiara: Pepsodent rimuove quella patina e fa tornare il tuo sorriso luminoso.
In pochi anni, l’America intera si lavava i denti ogni mattina. Per bellezza, non per igiene.
Perché Hopkins aveva capito che le abitudini non si costruiscono con i dati, ma con le emozioni.
La promessa, il motivo, l’azione
Per Hopkins ogni annuncio doveva rispondere a tre domande:
- Cosa prometti?
- Perché dovrei crederti?
- Cosa devo fare adesso?
Ogni sua pubblicità era costruita come una sequenza logica e psicologica. Il lettore entrava nel testo con un’attenzione vaga, ma ne usciva con una motivazione precisa e una chiamata all’azione.
In questo senso, Hopkins è il padre del copywriting moderno.
Ma anche qualcosa di più: è il primo che ci mostra come non serve urlare per farsi ascoltare. Serve parlare alla parte giusta della mente.
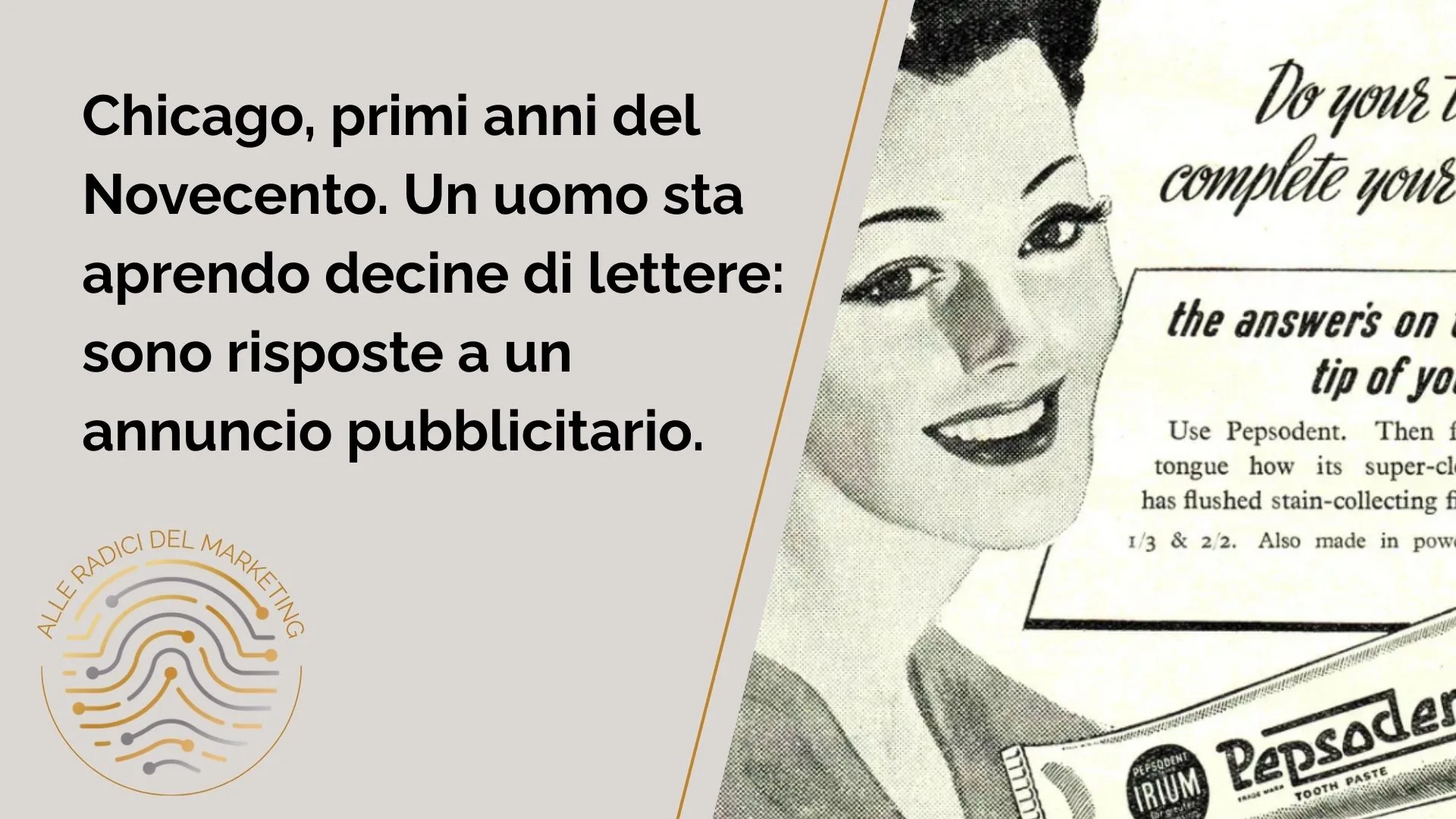
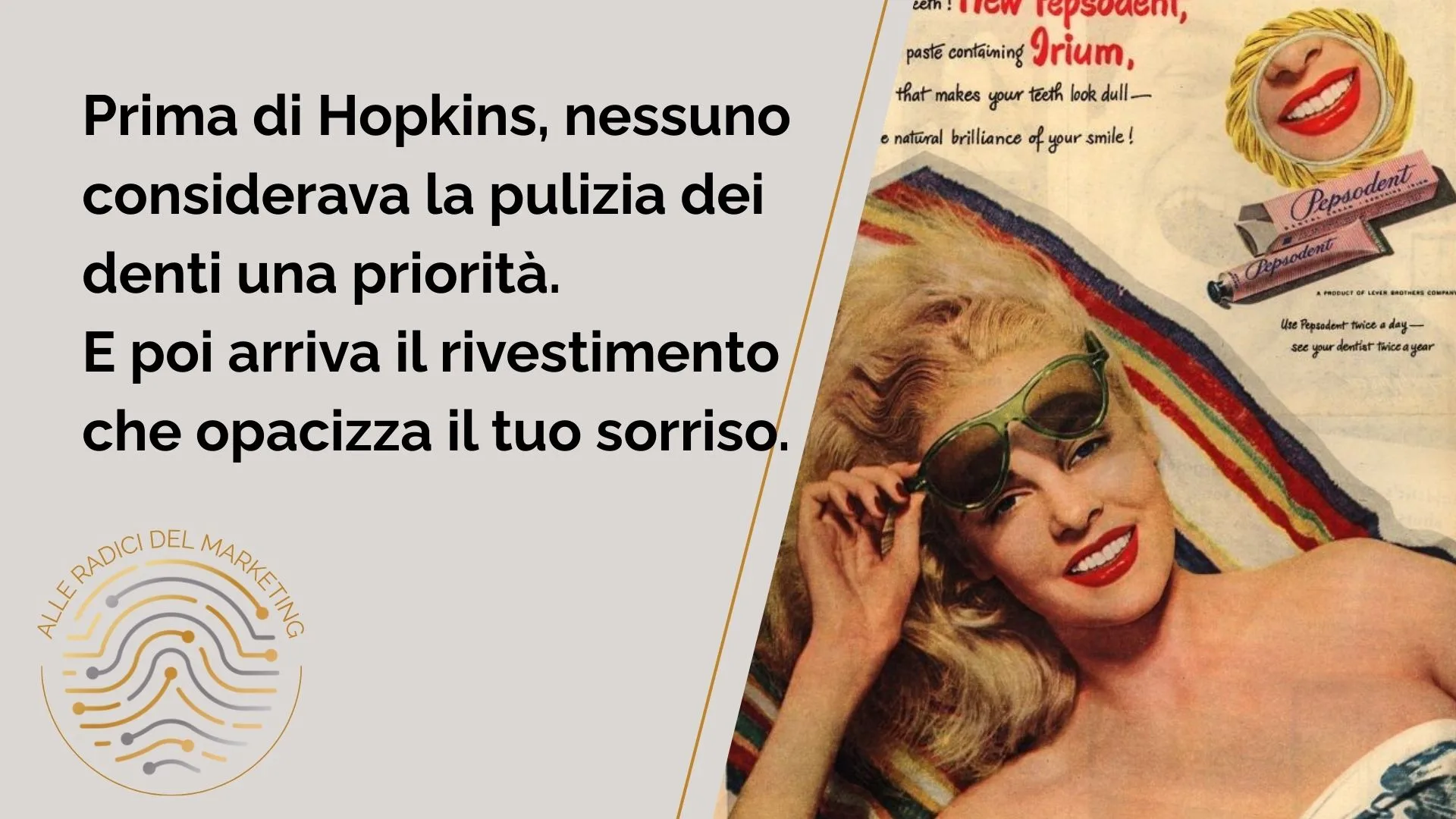
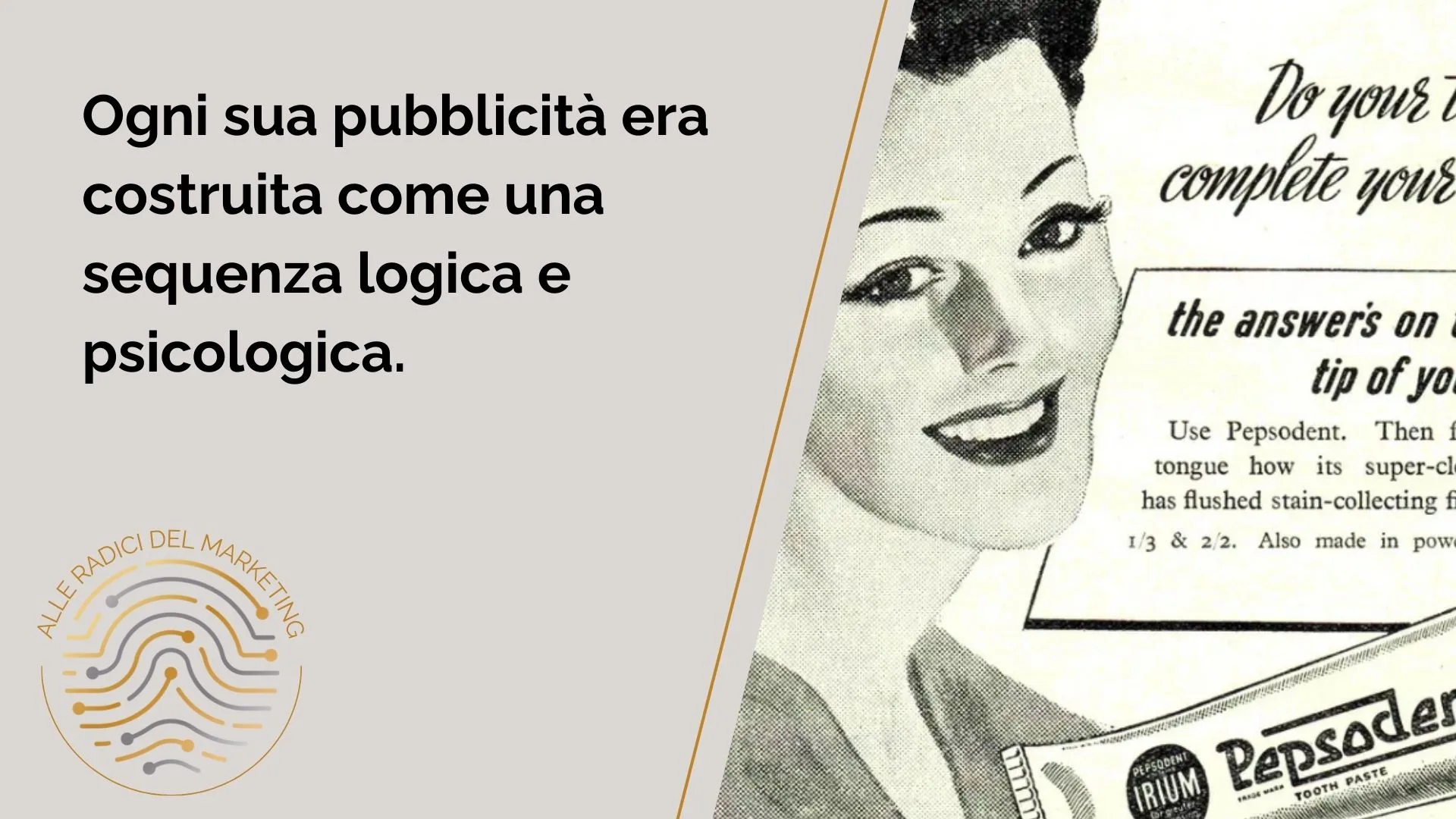
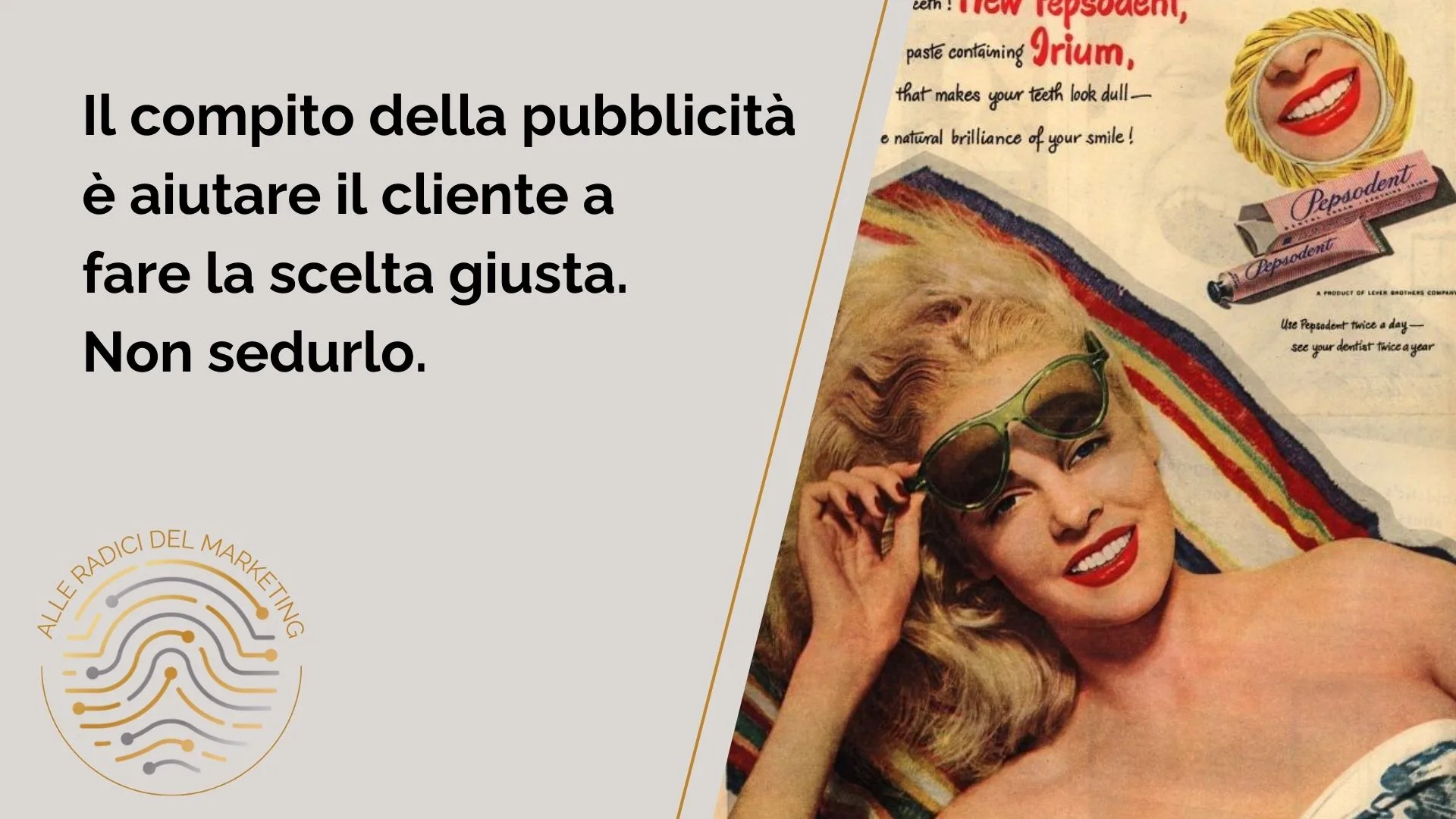
Testare, adattare, migliorare
Una delle sue idee chiave era che non esiste pubblicità efficace senza misurazione.
Scriveva due versioni di uno stesso annuncio, li faceva pubblicare in due città diverse, e poi analizzava quanti ordini riceveva da ciascuna.
Se la versione A batteva la versione B, la A veniva migliorata e testata di nuovo.
Era il metodo A/B testing molto prima che il digitale lo rendesse comune.
Hopkins usava le vendite come termometro della persuasione.
Se qualcosa funzionava, lo teneva. Se no, lo cambiava.
In questo modo, costruiva pubblicità sempre più efficaci, sempre più aderenti alla realtà delle persone, non alla fantasia dei creativi.
La pubblicità non è per vendere, ma per servire
Uno degli aspetti meno noti — e forse più affascinanti — del pensiero di Hopkins è la sua visione etica della pubblicità.
Per lui, il marketer non doveva essere un manipolatore, ma un facilitatore.
Scriveva:
“Il compito della pubblicità è aiutare il cliente a fare la scelta giusta. Non sedurlo. Non imbrogliarlo. Solo rendergli più facile ciò che già vuole fare.”
Una frase semplice, ma che oggi suona quasi rivoluzionaria.
In un’epoca in cui l’attenzione è sempre più costosa, Hopkins ci ricorda che il rispetto è una strategia vincente.
L’eredità invisibile
Hopkins non fondò scuole, non lasciò imperi, non cercò gloria.
Ma il suo pensiero è dappertutto, invisibile come l’aria: nelle pagine di vendita ben scritte, nei funnel ottimizzati, nei messaggi che ci fanno cliccare.
Ogni volta che misuriamo un risultato, che testiamo due versioni di una creatività, che ottimizziamo un titolo o una call-to-action, stiamo camminando nel solco che lui ha tracciato.
Fonti
- Library of Congress e Barnes & Noble: contenuti del libro e tecniche avertising
Investors.com / Glide Design: rilevanza storica del testo GLIDE® – Austin Web Design - Claude C. Hopkins, Scientific Advertising (1923)
- Claude C. Hopkins, My Life in Advertising (1927)
- David Ogilvy, Confessions of an Advertising Man
- Jeffrey L. Cruikshank, The Real Mad Men: The Renegades of Madison Avenue
- Harvard Business Review Archives – Advertising History
- University of Michigan Library – Advertising Ephemera Collection
- American Marketing Association Archives
- AdAge – “The Godfathers of Advertising”
Nel prossimo episodio…
Voleremo a Parigi, negli anni ruggenti del primo Novecento, dove l’arte, la pubblicità e la cultura popolare si fondono nei manifesti di Jules Chéret e Leonetto Cappiello.
Perché prima di Instagram, la bellezza del colore e la forza di un’immagine sapevano già vendere qualsiasi cosa.
Articolo di Dreamers Agency
